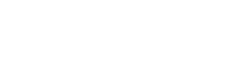2/1/2006 ore: 12:28
"Commenti&Analisi" La tentazione del mercato che travolse i manager rossi (E.Berselli)
Contenuti associati
IL RETROSCENA Le tappe della svolta: l´Unipol diventa spa, la Cmc di Ravenna vince l´appalto delle Autostrade E che anche le masse, per l´appunto, si sarebbero messe alla svelta su quattro ruote. Si apriva un mercato e le coop rosse erano lì, puntuali. Pronti gli uomini della Legacoop, che avevano già capito qualcosa del mercato (e del supermercato): pronti e rispettosi della politica di Botteghe Oscure, ortodossi sulla linea, stalinisti quando lo richiedeva il centralismo democratico, ma anche svegli e soprattutto pragmatici. E adesso, dopo la fragorosa caduta di Giovanni Consorte e delle varie consorterie? La Lega le è un colosso malato? Il suo destino consiste nel diventare una specie di Confindustria delle coop? Fermi tutti, ribattono alla Lega. Il "movimento cooperativo", come amano dire dirigenti e base, ha una storia lunga. Nasce nell´Ottocento, evoca echi mazziniani e di socialismo umanistico, accompagna l´ascesa socialista nell´età giolittiana, e sopravvive perfino sotto il fascismo. La Costituzione repubblicana ne riconosce la funzione sociale all´articolo 45. Nell´immediato secondo dopoguerra, Palmiro Togliatti ci mette le mani sopra, spedendo alla presidenza il duro e puro Giulio Cerreti. «È una tipica vicenda del frontismo», spiega il modenese Lanfranco Turci, oggi senatore ds, «cooperatore in prestito» come presidente della Lega fra il 1987 e il 1992: «c´è un controllo ferreo da parte togliattiana, perché nelle organizzazioni di massa vige una parità teorica fra Pci e Psi, ma in pratica l´egemonia è comunista, comanda il Pci, e i vertici sono di un colore solo». Per Togliatti le Coop erano uno degli elementi della cinghia di trasmissione, che legava il Pci e le organizzazioni di massa collaterali: partito, sindacato, cooperative, alleanza dei contadini, associazioni dei mezzadri, commercianti democratici. Una miriade di microimprese, gestite spesso paternalisticamente, create spesso dalla manodopera espulsa dalla prima ristrutturazione industriale postbellica, a cui l´ombrello del Pci offriva un riparo. Nessuno aveva in mente che il mondo cooperativo potesse essere un modello sociale ed economico alternativo al capitalismo: anzi, il materialismo dialettico si trascinava dietro la diffidenza di Marx e di Lenin, ma anche dei socialdemocratici alla Bernstein, verso la cooperazione, «un palliativo dell´economia borghese» inventato nell´Inghilterra manchesteriana dai Probi Pionieri di Rochdale, pallide correzioni laburiste, sentori di Fabian Society, con le utopie di Owen sullo sfondo, e l´Unità che scriveva «il socialismo non è una somma di cooperative». C´era un´autodifesa, questo sì, ma anche lo slancio. I 12 fondatori della Cooperativa Bilanciai, un´azienda di Campogalliano (settemila abitanti, appena fuori dal casello dell´Autobrennero), uscirono dalla fabbrica madre dopo un conflitto sindacale durissimo, e oggi sono un gruppo multinazionale e "glocal", che ha più di 500 dipendenti e fa acquisizioni in America. Eppure il controllo dal centro era fortissimo. La continuità fra il Pci e le altre realtà di massa, indiscussa. Se nel 1956, invasione sovietica dell´Ungheria, gli intellettuali dissentono, Antonio Giolitti se ne va, il segretario cigiellino Giuseppe Di Vittorio sfiora l´eresia, la Lega è tetragona. Non ha il ruolo esplicitamente politico del sindacato, vive la propria realtà con uno stringente senso dei propri limiti. L´indizio principale lo si trova scorrendo l´elenco delle presidenze nazionali, tutte targate falce e martello o Quercia: il modenese Onelio Prandini, il reggiano Valdo Magnani (proprio lui, uno dei due "Magnacucchi" esecrati da Togliatti come pidocchi nella criniera del destriero comunista), il bolognese Vincenzo Galletti, l´altro bolognese Giancarlo Pasquini oggi senatore ds, il già citato Turci, l´attuale presidente Giuliano Poletti. Tutta gente della casa comune, rossa ed emiliana. E quasi tutti sulla direttrice Reggio-Modena-Bologna, la via Emilia del socialismo. A riprova che l´osmosi fra il partito e la Lega era un meccanismo fisiologicamente perfetto. Basta guardare la geografia delle Coop per vedere che si sovrappone quasi esattamente all´area governata dal Pci: «Un connubio non tanto casto fra giunte e coop rosse», dice Giovanni Salizzoni, l´ex vicesindaco di Giorgio Guazzaloca uscito dalla scuola di Nino Andreatta: «Prima di Tangentopoli avevo sostenuto che la struttura della cooperazione era il grande finanziatore occulto del partito. Partito e Legacoop a Bologna erano tutt´uno, una struttura compatta, un mutuo potere capillare fatto di scambi in natura, appalti guidati, pubblicità nelle feste dell´Unità. Una volta feci scandalo dicendo che il sindaco di Bologna Renzo Imbeni poteva facilmente confondere la federazione del Pci con la sede delle Coop. Ma quando arrivammo noi, con Guazzaloca, questa struttura di potere si era già dissolta». Quando finisce il collateralismo? Secondo Turci uno dei punti di svolta risale al passaggio fra anni Sessanta e Settanta, allorché si sviluppò un esplicito dibattito sul superamento dell´egualitarismo. Le imprese cominciavano il loro aspro faccia a faccia con il mercato: «E i dirigenti, i manager dovevano essere pagati di più, dovevano viaggiare, negoziare, non potevano andare in giro con le pezze nel didietro». Inoltre, aggiunge Turci, il nuovo ruolo e le nuove responsabilità dei quadri direttivi ebbero un peso fortissimo nello spingere le imprese cooperative verso l´autonomia dalla politica: «L´osmosi fra il partito e le organizzazioni non aveva più senso: se una coop doveva farsi largo nel mercato, non si poteva mandare a dirigerla uno che aveva fallito nel sindacato». L´altra simbolica breccia nel muro dell´apartheid rossa si apre quando il gigante Cmc di Ravenna (una delle coop che oggi con la Sacmi di Imola, Cmb di Carpi e la Coopsette di Reggio Emilia costituisce l´hard power economico della Lega) vince un appalto delle Autostrade, acquisendo una dimensione nazionale. Più tardi, a metà degli anni Ottanta, c´è la trasformazione di Unipol in spa e il suo ingresso in borsa. Ed è su queste basi che nasce "il" problema. Il problema è un vistoso cambiamento di contesto, perché di fatto scompare il socio di riferimento. La Bolognina di Occhetto indebolisce inevitabilmente la presa dell´Elefante rosso, il partito deve concentrarsi sulla propria metamorfosi e sopravvivenza. E quindi nascono serissimi dilemmi di governance. Perché occorre pensare a un´impresa "diffusa", con una proprietà frazionatissima, composta da 12 mila aziende attive, con 7 milioni di soci, 400 mila dipendenti, poca industria e un futuro nella grande distribuzione e nella cooperazione di servizio. Se prevale la logica d´impresa, nasce subito un´anomalia: la normale dialettica fra azionisti e management è tutta sbilanciata dalla parte dei dirigenti. «Viene meno la capacità di "vigilanza", e questo spiega anche la parabola di Consorte, quello che ho definito bonapartismo manageriale», commenta Turci: «Anzi, in questo caso si ha l´impressione che fosse Unipol a dare ordini, o comunque a suggerire strategie, come faceva Consorte con il tesoriere dei Ds Sposetti». Informa tu Fassino, ma «per sommi capi», senza troppi dettagli. Certo, a parlare con la dirigenza coop in questi giorni, ci si accorge che un legame c´è ancora. «Sempre più tenue», dicono nella sede bolognese, «visto che nel 2001 non siamo stati neanche capaci di trovare una candidatura per un ex presidente di valore come Ivano Barberini». Tutti citano Pier Luigi Bersani come riferimento, e indicano comunque una collocazione della Lega nel centro perfetto del mainstream Fassino-D´Alema. Ma gli interessi della Lega sono gli interessi della Lega. Oggi sono possibili decisioni politiche una volta impensabili. Ad esempio, all´inizio della legislatura la Lega ha firmato con il governo Berlusconi il Patto per l´Italia (che invece la Cgil ha respinto). Cambia tutto. Allora anche l´atteggiamento verso il governo di destra? Dopo la vittoria del 2001, Berlusconi e Tremonti minacciavano sfracelli, spezzeremo le reni alle cooperative rosse. Alla fine, hanno fatto la riforma del fisco cooperativo e del codice senza toccare i cardini statutari della cooperazione, cioè l´inalienabilità del patrimonio e la proprietà indivisibile, in buon accordo con i vertici del mondo cooperativo. A questo punto il collateralismo è un´eco di simpatia a sinistra, di convegni sulla responsabilità sociale delle imprese, di bilanci "sociali", di valori "etici" invocati quando gli affari scottano. Lì davanti c´è il mercato, e il mercato non fa sconti a nessuno: né alla politica né alla storia della Lega. |