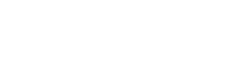15/5/2003 ore: 10:45
"Cultura&Informazione" Sindacati in Germania, il declino dei giganti
Contenuti associati
Giovedì 15 Maggio 2003 - N. 132
La crisi tedesca
Meno iscritti, difficoltà finanziarie e calo della contrattazione collettiva spingono le organizzazioni dei lavoratori a contrastare l’attuale riforma socialdemocratica dello Stato sociale - È in gioco lo storico legame con l’Spd
Sindacati in Germania, il declino dei giganti
Manifestazioni il 24 maggio per recuperare consensi
e salvare la forza di influenza
DAL NOSTRO CORRISPONDENTE
FRANCOFORTE Giancarlo Pajetta raccontava che nel lungo
periodo trascorso in carcere negli anni ’30 aveva imparato il tedesco,
ai tempi la lingua dell’Internazionale comunista. Chissà se oggi
avrebbe lo stesso istinto? A 70 anni di distanza, la Germania non
è più un modello politico per la sinistra europea: la socialdemocrazia
naviga a vista e il sindacalismo è alla ricerca disperata di una nuova identità. Per oltre un secolo, le grandi centrali sindacali tedesche
sono state uno straordinario modello di organizzazione, capaci
forse come nessun altro organismo in Europa di influenzare la
vita politica e sociale di un Paese. Per decenni, sono state al centro
di un sistema votato al consenso che ha permesso alla Germania di
diventare agli occhi di molti un paradiso sociale.
Sindacati in crisi. Oggi, i sindacati tedeschi sono in crisi. Certo,
continuano a sedere negli organi decisionali di numerosi enti pubblici
o semipubblici e nei consigli di sorveglianza di moltissime aziende
private; ma devono fare i conti con una graduale terziarizzazione
dell’economia, un netto calo degli iscritti, la perdurante stagnazione
congiunturale, e un peso nella società tedesca sempre minore.
In questo contesto, la riforma al welfare state proposta dal cancelliere
socialdemocratico Gerhard Schröder per risanare uno Stato sociale vicino al tracollo finanziario è considerato come un’ulteriore minaccia dal mondo sindacale tedesco. In queste settimane i sindacati
hanno protestato contro misure troppo dolorose: «Sì alle riforme.
No allo smantellamento dello Stato sociale!», è diventato lo slogan
della confederazione Dgb. «In crisi di rappresentanza e in
difficoltà finanziaria, i sindacati tedeschi vedono nell’opposizione
alle misure di riforme proposte dal Governo — tra le quali si
contano una riduzione dei sussidi di disoccupazione e un allentamento
delle norme sul licenziamento — un’occasione per arginare un drammatico calo degli iscritti», sostiene Wolfgang Streeck,
direttore dell’istituto Max-Planck di Colonia.
Una lunga storia. I grandi sindacati tedeschi — IG Chemie nel
1890 e IG Metall nel 1891 — nascono alla fine dell’Ottocento.
Consapevole della necessità di mantenere l’ordine sociale durante
la rivoluzione industriale, il cancelliere Otto von Bismarck consente
alla classe operaia nascente di organizzarsi e difendere, entro certi
limiti, i propri interessi.
Con la morte di Bismarck, nel 1898, i sindacati si rafforzano. L’organizzazione più importante —lefreie Gewerkschaften, vicine
all’Spd —registra un aumento progressivo degli iscritti: 50mila nel
1877, 680mila nel 1900, un milione nel 1904, due milioni nel 1910,
e due milioni e mezzo nel 1913. Prima dello scoppio della Prima
guerra mondiale, questa organizzazione conta 130 uffici e 3mila dipendenti.
Tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, nasce anche la
cogestione, quel principio che permette ai rappresentanti dei lavoratori
di sedere nei consigli di sorveglianza delle imprese e influenzare
il futuro dell’azienda. La Mitbestimmung è introdotta ufficialmente
negli anni ’20, ma viene sospesa dal regime nazista che nel 1933
abolisce anche i sindacati, destinati poi a riemergere con la fine
della guerra.
A insistere perché abbiano un ruolo importante nella società tedesca
sono in quel momento anche le forze militari inglesi, complice la
presenza a Londra di un Governo laburista e di un ex sindacalista,
Ernst Bevin, al Foreign Office.Forte del principio della cogestione
e grazie al miracolo economico del dopoguerra, il sindacalismo tedesco diventa un elemento centrale della vita politica, economica e
sociale della Germania.
Pace sociale. Per tutta la seconda metà del XX secolo prevale nel
Paese la pace sociale, ottenuta attraverso stipendi generosi e orari
del lavoro accomodanti. «Grazie a un quasi monopolio della rappresentanza e a una forte concentrazione per settore industriale,
i sindacati tedeschi non si occupano solo degli interessi particolari
dei propri iscritti, ma hanno anche un ruolo evidente di influenza politica, assai più importante di quanto non avvenga in altri Paesi
d’Europa», afferma Bernhard Wessels, professore al Wissenschaftszentrum di Berlino.
L’influenza dei sindacati è direttamente proporzionale al loro peso
finanziario. In media, la quota associativa delle organizzazioni
sindacali tedesche è dell’1,0% dello stipendio lordo mensile.
Con il miracolo economico degli anni ’50 e ’60 i sindacati tedeschi riescono a rafforzarsi e per molti anni IG Metall, che raggruppa i lavoratori metalmeccanici, è il più grande e forse il più ricco sindacato
al mondo.
Le quote associative non servono solo a gestire l’organizzazione, spesso complessa e capillare. Il denaro serve anche a finanziare gli scioperi, l’arma con la quale imporre alle imprese i rinnovi contrattuali: IG Metall, per esempio, offre quale compenso al lavoratore in sciopero una somma settimanale pari a 12-14 volte le quote versate dall’iscritto.
Negli anni ’80, la confederazione sindacale Dgb — a cui fanno
capo otto organizzazioni sindacali —era proprietaria di una banca, di
una società assicurativa, di un’agenzia di viaggi, di numerose
quote azionarie, e fino al 1986 di Neue Heimat, una società di sviluppo
immobiliare. Questa lobby finanziaria ha subìto negli ultimi 20
anni un netto ridimensionamento.
«Le organizzazioni sindacali in Germania hanno subìto almeno tre
shock», riassume Streeck. Il primo giunge negli anni ’80 con la crisi
di Neue Heimat sulla scia di uno scandalo di malversazione e la successiva vendita della Bank für Gemeinwirtschaft.
In quella occasione i sindacati perdono un’importante fonte di reddito.
Il secondo shock è legato all’unificazione che i sindacati della Germania Ovest videro come un’opportunità per rafforzare il loro ruolo inglobando le organizzazioni dell’ex Ddr. La struttura dei sindacati tedeschi crebbe sì in pochi mesi, ma senza che questa crescita fosse sostenuta da un aumento durevole degli iscritti. «Gli organismi sindacali — spiega Streeck —si resero conto improvvisamente che ai cittadini dell’Est dopo aver vissuto per 60 anni con l’obbligo di iscriversi a una moltitudine di associazioni interessava una sola cosa: il marco tedesco». Lo smacco a Est si accompagnò ad un altro shock: il netto calo degli iscritti a Ovest. Il numero dei membri della Dgb è calato da 11,8 milioni nel 1991 a 7,7 milioni nel 2002.
A giocare è stata la terziarizzazione dell’economia, ma anche l’aumento
graduale della disoccupazione strutturale: «Dalle nostre ricerche,
emerge forte il legame tra aumento dei disoccupati e calo degli
iscritti a un sindacato», spiega Wessels, riferendosi a un tasso di
disoccupazione che ormai in Germania è dell’11%. Una sensibile
diminuzione degli iscritti si traduce in bilanci sempre più risicati.
Certo la Dgb continua ad avere un patrimonio di quasi 500 milioni di
euro (tra cui quote azionarie per 100 milioni di euro), ma come
spiegare se non con la crisi finanziaria la nascita nel 2000 di un
nuovo sindacato dei servizi, Verdi, che raggruppa cinque diverse associazioni? A questi tre fattori bisogna aggiungere il progressivo scollamento della contrattazione collettiva.
Sono sempre più numerosi i rinnovi salariali che avvengono al di fuori
del quadro federale o regionale.
In calo di popolarità, ai sindacati tedeschi non resta che una rendita
di posizione: sono sempre presenti nei consigli di amministrazione
delle reti televisive, nei tribunali del lavoro, nei partiti politici (il
74% dei deputati Spd è iscritto a un’organizzazione sindacale) e negli enti pubblici che in un modo o nell’altro gestiscono la spesa per il welfare (come per esempio l’Ufficio federale del Lavoro). In questa ottica, il futuro dello Stato sociale diventa una partita per la stessa sopravvivenza del sindacato, che con la crisi economica, strutturale più che ciclica, teme di essere emarginato non solo nella società ma anche nella gestione attiva della cosa pubblica.
Forse come non mai in questi ultimi 100 anni, Spd e organizzazioni
sindacali sono spaccate e hanno interessi sempre più divergenti.
La Dgb ha indetto per il 24 maggio dimostrazioni in tutto il Paese:
non a favore di un rinnovo contrattuale o di prerogative sindacali,
bensì per manifestare contro una riforma dello Stato sociale proposta
dal partito socialdemocratico.
In realtà, il dibattito di questi giorni non riguarda tanto e solo il welfare
state; ma anche e forse soprattutto la stessa natura della socialdemocrazia tedesca e il ruolo dei sindacati in Germania.
BEDA ROMANO
LA CRISI
TEDESCA