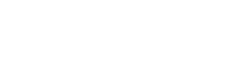|

giovedì 10 marzo 2005
Storia di Alia, «assistente familiare» 33enne di Tirana: è una delle 7 mila donne straniere che a Bologna hanno un ruolo oramai indispensabile nell’assistenza agli anziani
«Con il mio lavoro di badante risolvo tanti problemi a una famiglia»
Chiara Vergano
BOLOGNA Fino a poco tempo fa apparteneva a quell'esercito silenzioso che, solo a Bologna città, conterebbe circa 7000 donne. "Badanti", come vengono comunemente indicate, "assistenti familiari", come sarebbe più giusto chiamarle.
Alia - è di lei che parliamo - 33 anni, albanese, diplomata a Tirana in tecnologia, dalle case dei bolognesi è passata ai treni, dove ora lavora facendo assistenza ai clienti. In Italia è arrivata tre anni fa con un visto tedesco, come turista, e vi è rimasta tra mille difficoltà. «Sapevo che non sarebbe stato facile - racconta - ma non fino a questo punto. Ero disperata, avevo lasciato i miei figli in Albania, non avevo idea da che parte iniziare: ho toccato il fondo e mi sono dovuta rialzare per forza...». Alia ha lavorato in diverse famiglie, «l'esperienza è sempre stata buona. Mi hanno messo in regola, sono riuscita a ottenere il permesso di soggiorno...».
Arrivare alle famiglie, però, non è stata un'impresa semplice, e Alia ce l'ha fatta con l'aiuto del Servizio sociale della Parrocchia del Sacro Cuore: «All'inizio c'è un po' di diffidenza, ci vuole qualcuno che ti presenti». Un anno fa è riuscita a far venire i suoi figli in Italia: «Adesso sono felice di stare qui, con loro. Ma che fatica, tra permesso di soggiorno, la casa e tutte le difficoltà che uno straniero deve superare». Settemila solo a Bologna. Oltre 50.000 in tutta l'Emilia-Romagna. Dall'Ucraina, dalla Moldavia. Dall'Est.
«Assistenti familiari»: Alia ha raccontato la sua esperienza ieri a Palazzo d'Accursio nel corso del seminario su "Donne e lavoro di cura", promosso dalla Settima commissione consiliare del Comune e aperto dalla presidente, Donata Lenzi. Un'occasione per fare il punto su un universo vastissimo, straniero - e qui uno dei nodi cruciali resta l'emersione del lavoro nero - ma anche italiano, che si occupa di anziani, disabili, bambini. «Le assistenti familiari straniere in regola hanno un contratto di lavoro domestico, che prevede un massimo di 54 ore settimanali - spiega Lorenza Salsi (Acli colf) -. Lo stipendio? Ottocento euro lordi al mese, con vitto e alloggio. Ma alla famiglia, che deve versare i contributi, l'assistente costa 1200 euro mensili». Spese non indifferenti, eppure la richiesta è altissima, per quello che è un mercato prevalentemente "in rosa". Ad occuparsi di terza età ed infanzia sono infatti per la maggior parte donne: superano quota 8000 (escluso il settore della sanità ospedaliera), tra città e provincia, se si contano solo quelle inserite nella cooperazione sociale.
I problemi? «Non c'è un riconoscimento adeguato, economico e professionale - sottolinea Rita Ghedini, presidente della cooperativa sociale Cadiai -. Inoltre, la maggior parte degli assistiti non considera il lavoro svolto come una professione vera e propria. Piuttosto, una sorta di volontariato. Eppure si tratta persone qualificate, a livello sia di base che specifico». Su quest'aspetto è intervenuta anche Flavia Franzoni: «C'è un problema di valorizzazione di queste professionalità che ha a che fare, in generale, con la considerazione del lavoro di cura, trascurato sia a livello di retribuzione che di apprezzamento sociale. Un assistente di base, un educatore, difficilmente supera i 1000 euro al mese».
Sempre più assistenti familiari straniere si occupano degli anziani, «è un fenomeno emblematico del nostro tempo, dove occorre intrecciare politiche per la terza età e politiche dell'immigrazione. Affrontare il discorso delle “badanti”, che dedicano agli anziani la quasi totalità del loro tempo, vuol dire valorizzare il loro lavoro e qualificare l'assistenza che prestano». Ma c'è anche un altro punto su cui riflettere: «Riguarda la donna in generale - conclude Flavia Franzoni - e il lavoro di cura svolto quotidianamente in famiglia. In questi ultimi anni si sono sviluppate politiche sociali innovative, le persone sono sempre più assistite a domicilio, i servizi per i disabili vengono personalizzati.
Paradossalmente, però, questo nuovo welfare sta impegnando ancora di più la donna nel lavoro di cura: se c'è un anziano in famiglia con problemi, i servizi vanno a casa, ma non per tutta la giornata. Tocca a lei, dunque, gestire la situazione nella sua interezza, e dei problemi, tutt'altro che semplici, che ne derivano».
|
 |