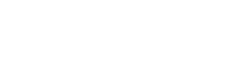Come è stato rubato il futuro ai ragazzi del Mezzogiorno
Contenuti associati
Il Sud è come in «gabbia»: luogo di cattività, di energie incatenate, di vincoli sociali e familiari che soffocano i destini individuali. È un Mezzogiorno sequestrato: da un politica nazionale che ha finito per danneggiarlo e per scaricare su di esso tutte le sue scorie, da classi dirigenti locali sempre subalterne agli interessi centrali per mantenere in cambio privilegi e rendite sul territorio. Un sequestro che ha l'età del nostro Stato, e che ha ridotto il Sud all'immobilismo,
in primo luogo sociale. Un patto implicito, su cui si è fondata l’Unità della nazione: al Meridione era assegnato il ruolo di «colonia di consumo» del Settentrione produttivo. E ciò era garantito dagli ampi trasferimenti dello Stato centrale verso i cittadini del Sud: un assistenzialismo funzionale all' intero sistema,non solo a beneficio dei meridionali «fannulloni». È per questo motivo che veniva tollerato e mai messo in discussione. (…)
ASSISTITI
Questo patto però ha finito per frustrare ogni capacità di iniziativa autonoma, per soffocare lo spirito capitalistico moderno, la propensione al rischio, all'intrapresa privata, ha legato il Mezzogiorno al palo di una dipendenza perversa. E ha garantito alle classi dirigenti politiche di sfruttare le leve improprie dell’assistenzialismo per riprodurre consenso e se stesse, e alle classi dirigenti economiche di sopravvivere e ingrassare con le rendite. Si era raggiunto un equilibrio, in cui il Meridione svolgeva una funzione nazionale, per quanto umiliante e, insieme, opportunistica. Questo equilibrio perverso non è venuto meno con il ricambio della classe dirigente dalla Prima alla Seconda Repubblica - che al contrario, nel passaggio, ha cercato il più possibile di conservare scambi e privilegi. Il patto perverso è saltato per fenomeni profondi. Il progresso tecnologico e le nuove migrazione dall'Est e dai Sud più a sud del Sud hanno reso sempre meno necessario l’apporto di «braccia» meridionali. La globalizzazione, poi, ha reciso il vincolo commerciale tra Nord e Sud del Paese, favorendo l'allargamento dei mercati di sbocco delle esportazioni settentrionali e offrendola possibilità ai meridionali di acquistare beni prodotti altrove. Da allora, i trasferimenti al Sud sono stati progressivamente mal tollerati: e si è diffuso nell'opinione pubblica centrosettentrionale - che ha conquistato
attraverso i grandi mezzi di comunicazione una presenza egemone nello spazio pubblico nazionale - quel luogo comune insidioso e un po’ razzista secondo cui ogni soldo trasferito al Sud nella migliore delle ipotesi è sprecato - come a Termini Imerese, appunto – nella peggiore finisce direttamente alle mafie. È una vulgata sempre più diffusa, ma che non racconta la verità. O meglio, non la racconta tutta. (…).Mai luoghi comuni sono continuamente riproposti e difficili da estirpare, non solo per il venir meno del vincolo (e dell'interesse) alla solidarietà territoriale, ma per gli elementi di verità che richiamano. Infatti, la denuncia dell'inadeguatezza della spesa non deve indurre nell’errore opposto di scaricare le responsabilità del declino meridionale solo sulle mancate politiche nazionali.
Porre la questione dei "volumi" di trasferimento di risorse pubbliche a Sud non significa non considerare, in un’ottica speculare, la necessità di far maturare nel Mezzogiorno una cultura politica e gestionale in grado di risolvere il groviglio politico-burocratico che da anni si autoalimenta. Gli sprechi sono stati tanto più intollerabili perché perpetrati in contesti di arretratezza profonda e di nuova miseria. Eppure, riconoscere i fallimenti delle recenti politiche di sviluppo non può portare a ritenere (...) che siano del tutto inutili o, peggio, dannose. Vanno corretti gli errori, prevenute le malversazioni, sanzionati gli illeciti. (...) Per liberare il Mezzogiorno bisogna iniziare a rompere legami, vincoli, circoli viziosi. E su tutti, il vincolo politico- economico tra interessi e consensi locali che alimentano interessi e consensi nazionali: ciò che ha impedito una funzione di sorveglianza e di sanzione del centro nei confronti di comportamenti o prassi locali aberranti. Fino a quel di più di aberrazione dei "premi" per le inefficienze nella gestione dei bilanci, fatti dal governo alle amministrazioni "amiche" di Catania e Palermo.