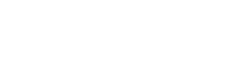|

 Lunedì 26 settembre 2005 Lunedì 26 settembre 2005
Finanza rossa - Rapporto sui bilanci dei 46 soci della Holmo Spa, la holding di Bologna che controlla l’Unipol e ne sostiene la scalata all’ex istituto del Tesoro
Coop, da dove vengono i soldi per la Bnl
L’investimento in banche e assicurazioni assorbe il 20% del patrimonio netto e sarà finanziato con il prestito sociale
di Massimo Mucchetti
Con la scalata alla Bnl le cooperative della Lega tentano la loro marcia su Roma o, più marxianamente, il loro assalto al cielo. Nessuno, anche solo un anno fa, avrebbe mai pensato che una compagnia di assicurazione guidata da un ingegnere abruzzese, con la tessera dei Ds in tasca e alle spalle 46 coop, fra cui una torinese di pompe funebri, potesse prendere le redini dell’ex banca del Tesoro, ricca di storia e di storie come i traffici d’armi con l’Iraq, le speculazioni della filiale di Atlanta, la costituzione della Fininvest, i rapporti con i partiti. Ma il sospetto con il quale è stata accolta Unipol non si spiega soltanto con gli interessi della Margherita, che ha buone relazioni con l’attuale vertice di Bnl ed è in concorrenza con i Ds. Questo sospetto nasce anche dal dubbio che le coop stiano spostando il baricentro verso il credito e l’alta finanza senza averne la vocazione, i mezzi e la qualificazione professionale. Luca Cordero di Montezemolo è l’interprete più famoso di questo pensiero critico. Per lui, presidente della Confindustria e della Fiat, le coop non dovrebbero uscire dal seminato, e cioè da grande distribuzione et similia .
Giovanni Consorte, il presidente di Unipol, sull’affare Bnl si gioca il posto e così cerca di smorzare i toni: «È stata una voce dal sen fuggita, una battuta estiva». Ma Montezemolo insiste. E allora a Bologna, dove ha sede il quartier generale di Holmo, la finanziaria delle coop che controlla, attraverso un’altra finanziaria allargata a investitori privati, il gruppo assicurativo Unipol, si ricorda che Montezemolo è socio e amico di Diego Della Valle, grande azionista di Bnl, avversario della compagnia bolognese e fieramente ostile a Consorte. Si ironizza sugli Agnelli che fanno gli equity swap e sulla Fiat che ha perso quel che ha perso con gli aiuti che ha avuto. Ma in privato. In pubblico, i toni sono altri. Pierluigi Stefanini, presidente della Coop Adriatica e di Holmo, dice: «Forse, prima di giudicare, Montezemolo dovrebbe studiare la cooperazione con la stessa umiltà con la quale noi studiamo il capitalismo privato. Lui dice: "Facciamo squadra". E noi di Holmo che cosa siamo se non una squadra?».
In effetti, sommando le 28 coop direttamente presenti in Holmo, viene fuori uno squadrone che fattura 15,6 miliardi, con oltre 75 mila dipendenti e un capitale investito di 17 miliardi, fornito all’88% dai 4,8 milioni di soci in parte sotto forma di capitale e riserve e in parte attraverso il prestito sociale. Uno squadrone che sembra guadagnare poco: 300 milioni nel 2004. Ma nelle coop la divisione del valore aggiunto obbedisce a finalità diverse dalle altre imprese. Pur incorrendo anch’esse in conflitti sindacali, le coop accrescono l’occupazione senza quasi mai ricorrere alla legge Biagi, spendono per formare il consumatore, vantano prezzi più bassi dell’inflazione. «Abbiamo un'altra testa - spiega Giuliano Poletti, presidente della Lega Coop . L’impresa cooperativa guarda ai tempi lunghi, accetta la sfida della globalizzazione ma resta legata al territorio. Dov’è finita la grande distribuzione che era in mano alla Fiat, a Berlusconi o ai Benetton? Le coop non scappano. La sera, nei bar di Imola i soci della Sacmi discutono dell’ultima alesatrice, dell’acquisto della Negri Bossi o del contratto con la Cina come dei mobili di casa. Per questo, i manager non possono cavarsela con la delocalizzazione, ma devono trovare la soluzione più difficile».
Solidarismo ottocentesco? Socialismo umanitario alla Andrea Costa? Le suggestioni antiche non aiutano. Questa forma di attività è marginale rispetto al complesso dell’economia, ma è sempre meno residuale. In mezzo secolo, la cooperazione ha aumentato gli addetti e pure la dimensione media delle imprese in un’Italia industriale sempre più atomizzata. Nel 1971 erano 8 le coop con più di mille dipendenti. Trent’anni dopo sono 55. Ma il grande balzo è avvenuto negli ultimi 10 anni. Nonostante il vuoto che, nel settore delle costruzioni sembrava aver lasciato la scoperta di Tangentopoli, alla quale anche le coop partecipavano, accanto ai privati, per intercessione di Pci e Psi. Motori della crescita sono stati lo sviluppo della grande distribuzione, l’outsorcing dei servizi delle imprese e della pubblica amministrazione, il boom del mattone e la ripresa delle opere pubbliche. Quattro opportunità che le coop hanno colto facendo leva sulla disponibilità a fusioni e ristrutturazioni difficili nel settore privato, sulla possibilità di governare con minori conflitti il lavoro, sulla continuità di una dirigenza che non punta solo alle stock option ; sulla capacità di reinvestire gli utili (al ritmo dell’80% l’anno).
Quest’ultima virtù è stata certamente incoraggiata da tanti anni di esenzione Irpeg e, ora, dalla limitazione dell’Ires. Un sussidio oggetto di ricorrenti critiche. Già nel 1994, dopo aver rilevato che le coop non avevano pagato l’imposta dello 0,50% sul patrimonio netto stabilita dal governo Amato, il ministro Tremonti tentò di lasciare gli sconti sull’Irpeg solo alle cooperative più piccole, ma le coop pagarono la patrimoniale e salvarono i benefici nel conto economico. Adesso, con la riforma Vietti, le coop a mutualità prevalente - in pratica, tutte - pagano l’Ires del 33% non sull’intero imponibile ma sul 30% dell’utile. All’atto pratico, tuttavia, questo risparmio non è gran cosa perché il valore aggiunto, come visto, viene scremato prima. Secondo una simulazione di Coop Adriatica, che fa un utile lordo di 29 milioni e paga 8,5 milioni di imposte, il risparmio effettivo sull’Ires rispetto alla tassazione teorica di una spa equivalente sarebbe di 4,8 milioni. Secondo un’altra elaborazione sui conti delle prime sei coop di consumo di Holmo, che negli ultimi due anni hanno dichiarato un utile lordo medio di 180 milioni pagandone 59 di imposte, il risparmio fiscale è di una trentina di milioni.
In ogni caso i benefici fiscali sono legati a limitazioni pesanti dei diritti di proprietà in capo ai soci. Basti pensare che il valore della quota non tiene conto del connesso valore patrimoniale contabile della coop e meno che mai del suo valore di mercato. Se esce, il socio della Coop Adriatica viene liquidato con 40 euro, mentre il valore contabile della quota è di 738 e quello di mercato oscilla di 1.500-1.700 euro. Lo Stato, dunque, rinuncia a un introito e il socio cooperatore fa altrettanto a favore di una speciale forma di impresa.
Ma la Bnl? Si fa tutto questo per la Bnl? Dal Regno Unito alla Svezia, dalla Germania al Belgio, coop e sindacati hanno o hanno avuto banche e assicurazioni dalle alterne fortune. Non ha senso stupirsi, dunque. Ma si può e si deve constatare che le 46 coop direttamente e indirettamente coinvolte in Holmo stanno per scalare un gradino molto alto rispetto alla storia gradualistica del loro sviluppo. Con Bnl, il conglomerato finanziario che fa capo a Unipol diventa il sesto in Italia per totale di attività e margini, a un’incollatura da Capitalia e addirittura il quarto per ricavi. Tra dipendenti e agenti schiererà 37 mila persone, la metà del totale dei soci di Holmo, e avrà un patrimonio netto di quasi 6 miliardi più o meno come i soci di Holmo.
L’altra domanda legittima è se con Bnl le coop non stiano rischiando l’osso del collo, e non solo la reputazione che può essere minata da impreviste difficoltà gestionali o dall’esito sfavorevole delle inchieste giudiziarie. Gli oneri di capitale, è vero, grazie alla catena societaria a monte di Unipol gravano solo per il 27% sulle coop. Ma è altrettanto vero che la conquista della banca costituisce un passo molto serio. A fine 2004, le 46 coop avevano investiti in Holmo e Unipol 800 milioni, pari al 12% del loro patrimonio netto aggregato. A fine 2005 si stima che il patrimonio si aggiri sui 7 miliardi, ma l’investimento allargato a Bnl salga ancora di più. La quota dell’aumento di capitale è infatti pari a 440 milioni e il 4% di Bnl acquisito da Coop Adriatica, Nordest, Nova Coop e Liguria ne costa altri 320. Dunque, nella partita bancario-assicurativa il rischio supera gli 1,5 miliardi, il 20% del patrimonio attuale.
L’investimento si finanzia attingendo soprattutto al prestito sociale, posto che i nuovi utili portati a riserva serviranno per lo sviluppo delle attività tipiche. Secondo le regole interne, la quota del prestito sociale che può essere reinvestita in immobilizzazioni materiali e finanziarie non può superare il 30% perché bisogna conservare sempre liquidità sufficiente a rimborsare a vista i sottoscrittori. C’è dunque un polmone di 3 miliardi che costa il 2% ed è usato solo in parte.
Paradossalmente lo spot più tranquillizzante lo ha appena fatto il consiglio della Bnl, presieduto da Luigi Abete, che ha varato una semestrale con 277 milioni di utile: una buona base di partenza per una banca che non ha mai avuto un «padrone». Certo, le coop stanno usando sempre di più lo strumento delle spa senza benefici fiscali e la Borsa. Dovrebbe essere una buona notizia per i tifosi del capitalismo: soprattutto se, all’americana, non temono gli outsider e, all’europea, ammettono che la social responsability delle coop possa offrire al pensiero unico almeno gli stimoli del pensiero laterale.
|
 |