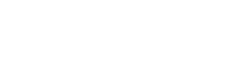2/11/2005 ore: 11:18
Generazioni McDonald’s
Contenuti associati
ANNIVERSARIO CATEGORIE A CONFRONTO SOTTO LA GRANDE «M»: COM’È CAMBIATO IL COSTUME, NON SOLO A TAVOLA Vent’anni fra paninari no global e famiglie Il fast food ha trionfato anche in Italia, patria della «cucina di una volta». Se, negli anni Ottanta, i panini di McDonald’s erano l’alimentazione più indicata per i paninari, la situazione si è nel tempo fatta più complessa, e politicizzata. Negli anni Novanta, quelli del distacco sempre più netto tra giovani e politica, le famiglie cominciarono a individuare in McDonald’s un luogo dove forse non si mangiava benissimo, ma venivano offerti pasti a prezzo accessibili. Poi iniziarono le prime proteste. La standardizzazione del gusto, le patatine che sapevano di pollo e viceversa, fecero arricciare il naso a molti. A Roma ci fu chi lanciò sassi contro un centro McDonald’s. E Marcello Mastroianni andò a mangiare un piatto di pasta in uno store della capitale. Nel 1997, gli U2 identificavano nel baffo giallo di McDonalds l’emblema della globalizzazione cattiva, facendolo troneggiare nel palco gigantesco del Pop Mart Tour. L’anno prima era uscito Il mondo alla McDonald’s di George Ritzer, in cui si sosteneva che i principi della ristorazione fast food (prevedibilità, velocità, managerialità, iperconsumo) si stessero imponendo anche nella scuola, nella politica. Nella famiglia. Il monolito contemporaneo, per i bambini, si chiama Happy Meal, è nato nel 1979 e ha partorito negli anni il Mighty Happy Meal (per chi ha 8-9 anni) e il Go! Active Adult Happy Meal. Alla base del successo, il binomio cibo più giocattolo. Con un «Mighty» ottieni un doppio cheeseburger, un doppio hamburger e un giocattolo. L’«Adult» include anche un’insalata, una bottiglia d’acqua minerale, un non meglio identificato «giocattolo per adulti» e - summa del politically correct - un libro sugli esercizi fisici, insostituibile abbecedario attraverso il quale il cliente può, se vuole, prontamente smaltire le vagonate caloriche appena ingurgitate. Dopo aver rivelato la compagnia dai fratelli McDonald’s, il magnate Ray Kroc comprese immediatamente come il bacino commerciale più redditizio fossero i bambini. Per questo valorizzò la figura del clown Ronald. Con una importante variazione. Se, nei primi anni, Ronald era un buffo personaggio che si rimpinzava di cibo, Kroc comprese le implicazioni negative di un simile messaggio e lo tramutò in icona benevola, che canta, balla, ridacchia e sorride ai bambini. Ma non mangia mai. Non è un caso che, nel 2003, assaltando un McDonald’s di Lugano, i no global manifestarono al grido di «Crepa pagliaccio». Come ha detto Morgan Spurlock, regista del documentario Super Size Me, nel quale si è nutrito per trenta giorni di solo cibo McDonald’s per dimostrarne gli aspetti negativi, «Kroc comprese che per le famiglie americane il McDo dovesse essere un posto che abbia a cuore, non che provochi attacchi di cuore». Oggi la lotta è sempre più velocità versus lentezza. Con la differenza che, in questo caso, il giochino celentaniano andrebbe in cortocircuito, perché a essere rock è la lentezza. Slow Food, ad esempio. Quest’ultimo si sofferma sui ritmi di lavoro «fordiano» di chi è assunto da McDonald’s, sulle paghe inique, sulle gratificazioni american-kitch come "operaio del mese". Sulla scarsa qualità del bestiame macellato in Italia (frisone a fine carriera, vecchie, dopate e spremute). E sull’inquietante composizione, stando almeno a London Greenpeace, di un hamburger di 80 grammi: 46 g di carne bovina macinata (lingua, cuore, grasso, cartilagini, tendini, intestino e altre sostanze organiche comprese); 10 g di carne recuperata meccanicamente dal resto della carcassa e poi tritata; 20 g d’acqua; 2 g di sale e spezie; 1 g di glutammato monosodico; 5 g di polifosfati e conservanti. Secondo questa non minoritaria teoria, il McDonald’s sarebbe un condensato di negatività. Il responsabile dell’obesizzazione di bambini poco controllati dai genitori. Il colpevole dell’estinzione del Puzzone di Moena, della Vacca Podolica del Gargano e di uno qualsiasi dei 198 presìdi Slow Food. Un prodotto malsano, destrorso, veloce (anche se la sua digeribilità è lenta, molto lenta). C’è però il risvolto della medaglia, che forse spiega più dei Ronald ridanciani il successo di McDonalds. Ovvero, il fatto che, se Slow Food è di sinistra, i prezzi delle ideologicamente corrette trattorie della nonna sono quasi sempre di destra. E in pochi possono permettersele. L’intellettuale Regis Debray, a proposito del mondo contemporaneo, ha detto che «gli oggetti si globalizzano e i soggetti tribalizzano». Paradossalmente, proprio tra i più giovani, c’è chi trova l’iperglobalizzazione di McDonald’s non deprecabile ma salutare. Come se quel cibo sempre uguale fosse, in qualche modo, rassicurante. Anche in Italia.
|