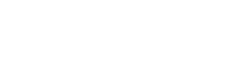14/10/2002 ore: 10:50
Il grande freddo su Torino un futuro da città-satellite -1-
Contenuti associati
| SABATO, 12 OTTOBRE 2002 | |
| Pagina 4 - Economia |
| L´incubo della fabbrica-cacciavite che produce e non progetta |
| Senza il Lingotto affondano anche le banche e il terziario |
| Il grande freddo su Torino un futuro da città-satellite |
| Con la crisi Fiat tramonta il primato industriale |
| Il sindaco Chiamparino: "Se hanno rinunciato a negoziare con gli americani siamo perduti: qui resteranno solo i semplici compiti di assemblaggio, addio alla ricerca e alla progettazione" |
| Dietro il declino della città c´è una sconfitta nazionale. Claudio Stacchini, della Fiom: "Con l´auto muore l´ultimo sistema industriale del Paese, dopo la fine della chimica e dell´informatica" |
| Il clima è già rassegnato: Mirafiori è un guscio semivuoto, i 200mila dipendenti degli anni ´80 si sono ridotti a 35mila |
| Andrea Pininfarina è pessimista sulla possibilità della città di trasformarsi in una Silicon Valley dell´auto indipendente |
| FEDERICO RAMPINI |
|
TORINO - «Il problema non è se vendere alla General Motors, ma a che prezzo». Nel giorno dello sciopero Fiat l´annuncio di Paolo Fresco al Wall Street Journal è di un candore imbarazzante. «Se è così siamo perduti, hanno già rinunciato a negoziare con gli americani sulle attività da mantenere a Torino» protesta il sindaco Sergio Chiamparino. La grande crisi della Fiat fa esplodere tensioni più disperate al Sud dove una fabbrica chiusa è una condanna senza appello. Mentre perfino il torinese Piero Fassino va a solidarizzare con gli operai di Termini Imerese, Torino vive un dramma che forse solo lei può capire davvero. Vede svanire per sempre quel ruolo nazionale che la storia le aveva affidato, di capitale della modernità industriale. E Torino ha l´impressione che l´Italia non veda: dietro il declino della città c´è una sconfitta nazionale. «Con l´automobile stiamo perdendo l´ultimo sistema industriale che era rimasto in piedi in questo paese, dopo la fine della chimica, dell´informatica» grida al microfono Claudio Stacchini, leader della Fiom di Mirafiori. «Di fronte a questo disastro non si manda via Cantarella con 42 miliardi di vecchie lire di liquidazione», protesta Ettore «detto il Cigno», della Uil. Sono le dieci del mattino, per lo sciopero di tutti gli stabilimenti Fiat davanti al cancello 5 di Mirafiori affluiscono in corteo poche migliaia di lavoratori. Eppure le percentuali di adesione sono buone, è che i grandi numeri non esistono più. E con 6.000 operai già in cassa integrazione, l´imponente edificio-fabbrica di Mirafiori è un guscio semivuoto. Il corteo con le bandiere rosse davanti al cancello 5 è un pallido ricordo della folla che Enrico Berlinguer arringava proprio qui 22 anni fa. Sembra lontanissimo quel terribile autunno del 1980: il terrorismo in fabbrica, i licenziamenti degli operai accusati di simpatizzare con le Br, la lunga occupazione di Mirafiori appoggiata dal Pci (ma perfino il Cardinal Pellegrino veniva in visita agli operai), preludio alla marcia dei quarantamila e a un periodo di sconfitte sindacali. Tom Dealessandri allora partecipava all´occupazione, operaio e militante Fim Cisl, oggi lavora al Comune, si aggira tra i manifestanti del cancello 5 e ricorda un esercito scomparso: «Nell´80 la Fiat aveva quasi 200.000 dipendenti, ne sono rimasti 35.000. Avanti di questo passo, e scompariamo per sempre dal gruppo dei paesi industriali produttori di automobili». Quel momento è più vicino di quanto si creda. La Spagna fabbrica più auto di noi, ma anche il Messico e il Brasile. «Non possiamo rassegnarci - dice Giorgio Airaudo, segretario della Fiom di Torino -. Tutti i grandi paesi europei conservano un´ industria automobilistica, solo noi stiamo mollando. E non ci sono tante alternative pronte per questa città. L´industria tecnologica è in crisi, le banche e il terziario senza l´industria affondano. Torino ha ancora bisogno dei suoi operai. Siamo ben lontani dal diventare una città di servizi come Milano e intanto abbiamo perso le telecomunicazioni, l´informatica: cosa resta della culla della civiltà industriale italiana?» Eppure qui non c´è una mono-cultura industriale. Attorno alla Fiat è cresciuto uno dei distretti industriali famosi nel mondo per la concentrazione di specialisti dell´automobile: dai produttori di componenti ai celebri carrozzieri, gli stilisti del design. Mille aziende e 70.000 persone, un concentrato di professionalità, tradizioni antiche, competenze avanzate. Andrea Pininfarina è il nome più noto: imprenditore di terza generazione, alla testa di un´azienda di design di fama internazionale, è anche il presidente dell´Unione industriali e rappresenta tutto «l´indotto» di piccole e medie aziende che producono (sempre meno) per la Fiat. «E´ vero - dice -, questa è ancora una città operaia e la paura si respira nell´aria quando migliaia di lavoratori vengono messi in cassa integrazione. Però sia la Fiat che l´industria in generale non hanno più la centralità di una volta. Vent´anni fa metà della popolazione attiva lavorava in fabbrica. Oggi è scesa a un terzo. E solo la metà di quel terzo lavora direttamente o indirettamente per la Fiat». Torino può sperare di conservare un distretto industriale di specialisti dell´automobile, indipendentemente dalla sorte della Fiat? La Silicon Valley ha migliaia di piccole imprese hi-tech, ma anche giganti come Intel, Hewlett-Packard, Cisco. Il Piemonte può coltivare l´eccellenza nel disegnare auto o fabbricarne alcuni pezzi, se deperisce il grosso compratore locale? Perfino Pininfarina, i cui principali clienti sono stranieri, ha qualche dubbio. Perciò, mentre Torino si abitua lentamente all´idea - sconvolgente fino a pochi anni fa - che la Fiat possa diventare straniera, la preoccupazione si sposta sul «come»: a che condizioni avverrà il passaggio sotto le insegne della General Motors. «L´incubo - dice il sindaco Chiamparino - è che la Fiat sia condannata a diventare una fabbrica-cacciavite, relegata a semplici compiti di assemblaggio. Mentre tutto il lavoro sofisticato, cioè la ricerca e la progettazione, avverrebbe altrove». Un destino da «maquiladora» messicana, insomma, come chiamano gli stabilimenti che le multinazionali americane delocalizzano a sud del Rio Grande. E´ da questa paura che nasce una «proposta indecente», che da alcuni giorni rimbalza tra le stanze dell´establishment finanziario ed ha echi anche nel dibattito politico nazionale. L´ha fatta propria nel modo più esplicito il sindaco di Torino, piace ai sindacati piemontesi e a Fausto Bertinotti. E´ l´idea che prima di vendere la Fiat Auto agli americani entrino nel capitale degli azionisti pubblici, magari con una partecipazione simbolica. Non è la prima volta che una crisi della Fiat alimenta progetti simili: a metà degli anni Settanta sotto l´effetto dello shock petrolifero si parlò di una sua «Irizzazione». Oggi i fautori di una iniezione di capitale pubblico additano il modello della Volkswagen - che ha per azionista la Regione tedesca della Bassa Sassonia - e della Renault dove lo Stato francese conserva una presenza. Ma una cosa sono le aziende storicamente pubbliche. Altro è nazionalizzare, sia pure per una piccola quota, la Fiat. E poi con quali mezzi, visto lo stato delle finanze pubbliche? Per non parlare della probabilità che un´operazione simile finisca sotto la lente del commissario europeo alla Concorrenza, Mario Monti, come infrazione ai divieti sugli aiuti di Stato. Lo stesso sindaco di Torino, che conosce le scarse disponibilità finanziarie degli enti locali, esclude di voler imitare la Bassa Sassonia e parla di un «chip»: una puntata simbolica nel capitale della Fiat Auto che consenta al Comune di partecipare al negoziato con gli americani e di vigilare sulla salvaguardia di occupazione «pregiata» a Torino da parte della Gm. Chiamparino dice: «l´ideale sarebbe andare anzitutto a una fusione tra Fiat Auto e Opel, sulla base di un progetto industriale europeo; e con una partecipazione azionaria anche da parte delle banche italiane». Ma il sistema bancario è già pieno di problemi. E come giustificare di fronte all´opinione pubblica l´ennesimo salvataggio della Fiat che costerebbe caro ai contribuenti, e forse non chiederebbe nulla alla famiglia Agnelli? «Mi rendo conto - dice Airaudo della Fiom - che il paese ha già pagato molto. Ma qui c´è un pericolo oggettivo di impoverimento industriale. Non si può accettare che l´Italia diventi solo un grande mercato di conquista per produttori stranieri, al massimo con qualche fabbrica-cacciavite ma senza più centri direzionali e di progettazione. Si rischia la perdita di un altro grande patrimonio tecnologico nazionale». «Ma allora perché non puntare su una strada completamente diversa - controbatte a ragione Pininfarina - e cioè essere capaci di attirare la Toyota ad aprire una fabbrica qui?» In un altro luogo simbolico della storia Fiat, al Lingotto, Torino si prepara intanto per una sfida completamente diversa: le Olimpiadi invernali del 2006. E´ una scommessa simbolica per tante ragioni. Porterà alla città nuove infrastrutture, un volano di sviluppo nel terziario (turismo e servizi) prezioso di fronte alla crisi Fiat. Ai vertici del comitato organizzatore c´è un personaggio non banale: Evelina Christillin, ex campionessa di sci, ricercatrice scientifica, moglie del neoamministratore delegato della Fiat Gabriele Galateri. Una donna che rappresenta bene una generazione e una nuova società civile torinese. Vent´anni fa militava in Lotta continua. Oggi si appresta a «muovere» 3.000 miliardi di vecchie lire di investimenti e non esita a dire: «Mi dà fastidio l´idea di Torino come città perdente, imbolsita. Preferisco pensare a quel che seppe fare nel 1864, quando perse di colpo il ruolo di capitale d´Italia, e seppe inventarsi una rivoluzione industriale». Il Lingotto, dove il Comitato Torino 2006 ha i suoi uffici, è in piena metamorfosi: trasformato da antica fabbrica a centro congressi e mostre, ora si arricchisce di cinema, sale spettacoli e shopping mall all´americana. Un´allusione a un possibile futuro post-industriale e post-moderno? «Non credo - dice la Christillin - che si possa rinascere come una Las Vegas italiana. No, i torinesi non sono quella cosa lì». (1 - segue) |