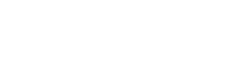La questione della rappresentanza per una Cgil a rischio «lobby»
Contenuti associati
In Cgil siamo ai materassi. Mancano più di tre mesi al congresso che dovrà scegliere il successore di Guglielmo Epifani e le accuse tra i due schieramenti che si contendono la guida della maggiore confederazione laburista d'Italia stanno salendo di tono. La seconda mozione, imperniata sulle due maggiori categorie (funzione pubblica e metalmeccanici), accusa la segreteria uscente di manipolazione dei dati: avrebbe cambiato in corsa le regole assegnando un maggior peso ai pensionati pur di ipotecare l’esito finale del congresso.
Per martedì prossimo si ventilano addirittura conferenze stampa contrapposte con annesse minacce di scoprire gli altarini. Chi pure ha auspicato che (finalmente) nella Cgil finisse la lunga stagione della paralisi e si aprisse un vero confronto sulle differenti opzioni strategiche, non può che masticare amaro davanti a quello che appare un mero regolamento di conti. Dall’immobilismo alla cruda lotta di potere. Le responsabilità accumulate in questi anni dalla segreteria Cgil sono ampie. Per ben due volte, prima con la presidenza di Luca di Montezemolo e poi con Emma Marcegaglia, Epifani ha scelto la via dell’Aventino. Se avesse per tempo favorito una riforma e articolazione della contrattazione avrebbe incassato i seguenti risultati: a) avrebbe usufruito degli anni della ripresa e non sarebbe arrivato dentro la crisi portandosi dietro una questione salariale così acuta; b) evitato di perdere i contatti con Cisl e Uil e rimanere isolato; c) dato nuova linfa alle categorie e alle organizzazioni periferiche della Cgil dove abbondano buoni contrattualisti che vogliono fare il loro mestiere. Se avesse operato queste scelte coraggiose e lungimiranti è assai probabile che sarebbe emersa a fianco a lui anche una nuova e credibile leadership. E oggi avremmo dentro la confederazione un confronto politico più trasparente e meno prosaico. Ma purtroppo è risaputo che la storia non si fa con i «se». La querelle sul presunto abuso dei pensionati nei calcoli pre-congressuali (e forse anche nell’organizzazione di manifestazioni di pura testimonianza) si presta poi a considerazioni più generali sul delicato tema della rappresentanza. L’impressione è che il sindacato — e non solo la Cgil a dir la verità— faccia volutamente confusione tra rappresentanza e massa critica. Quest’equivoco vale per come si rapporta ai pensionati ma anche per il tentativo in corso di tesserare i lavoratori autonomi con partita Iva. Se infatti scorporiamo dai dati sugli iscritti ai sindacati confederali proprio le falangi dei pensionati viene fuori che l’indice di sindacalizzazione dei lavoratori dipendenti è sceso dagli anni Settanta a oggi di una ventina di punti. Sono passati da circa il 50% a una cifra attorno al 30%. Un tracollo. E del resto non è nemmeno casuale che organizzazioni internazionali come Ue e Ocse nei raffronti tra Paesi per misurare l’effettiva rappresentatività dei sindacati escludano i pensionati e computino i soli lavoratori dipendenti attivi. Il guaio è che per ovviare al calo di rappresentatività e non perdere peso politico i sindacati confederali sovrastimano i pensionati e si muovono in direzione della conquista di nuovi mercati (i lavoratori autonomi, i giornalisti, un giorno persino la fascia bassa dei professionisti), ma così non fanno altro che caricarsi di rappresentanza impropria proprio nel momento in cui paiono indeboliti su quella di base, il lavoro dipendente. Da qui l’immagine di Cgil-Cisl-Uil come un gigante con i piedi di argilla, imponente per numero di tessere staccate ma in grave difficoltà nei luoghi di lavoro, soprattutto nelle piccole e medie imprese dove più spesso negli anni pre-crisi sono avvenute le assunzioni di giovani. Lo conferma un’indagine della Fondazione Nordest: solo il 17,3% dei lavoratori dipendenti under 24 riconosce al sindacato un ruolo attivo di tutela. Se al concetto di rappresentanza si finisce per sostituire de facto quello di massa critica il rischio è di una trasformazione implicita del sindacalismo italiano, da organizzatore delle tutele del lavoro dipendente a lobby, fortemente insediata a Roma ma scarsamente considerata nei territori. Per di più una lobby nella quale c’è il fondato pericolo che prevalgano, come sostiene il sociologo Paolo Feltrin, «le incrostazioni identitarie della Prima Repubblica» piuttosto che una moderna cultura del lavoro, capace di elaborare proposte e di tenere sempre alta la qualità della rappresentanza.