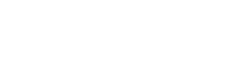30/11/2007 ore: 9:57
Scaricare i rischi d'impresa sui lavoratori (L.Cavallaro)
Contenuti associati
Prima Pagina (segue a pagina 9) la polemica Confinudistria, Cisl, l'articolo 36 della Cost. e la fregatura cioè scaricare i rischi d'impresa sui lavoratori Cosa remunera il salario o lo stipendio? Secondo la teoria economica dominante, la produttività marginale del lavoro, ossia la capacità del fattore lavoro di generare una quantità addizionale di prodotto impiegando un'unità di lavoro in più e mantenendo costanti tutti gli altri fattori. E perché proprio la produttività "marginale"? Perché, si dice, l'imprenditore non avrebbe convenienza alcuna a domandare un'unità aggiuntiva di un fattore il cui rendimento aggiuntivo è inferiore rispetto all'incremento di costo sopportato per procurarselo, né - s'intende - a tenerselo sul groppone se per errore l'avesse assunto. Questa concezione sembra avere un riferimento normativo diretto nell'articolo 36 della nostra Costituzione, che afferma solennemente che il lavoratore ha diritto a una retribuzione «proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro». Si tratta però di una cosa molto difficile da accertare. Assumendo che la norma costituzionale imponga di pagare di più quando si lavora di più o meglio, si postula, infatti, la possibilità di istituire un confronto nel tempo fra le prestazioni rese da un medesimo lavoratore e ci si espone a critiche difficilmente superabili non appena si considerino le asimmetrie informative che, affliggendo il mercato del lavoro non meno di qualunque altro mercato, rendono problematica la misurazione dell'impegno e di quelle altre caratteristiche personali del lavoratore dalle quali per ipotesi dipenderebbe la qualità (e dunque la remunerazione) della sua prestazione. Si potrebbe supporre che la difficoltà possa essere superata istituendo una comparazione intersoggettiva fra i lavoratori, in modo da individuare chi lavora di più o meglio attraverso il confronto con gli altri. Ma la strada è preclusa: la Cassazione ha infatti reiteratamente negato che dall'articolo 36 della Costituzione si possa evincere il principio che a parità di lavoro debba corrispondere parità di retribuzione e, con ciò, ha escluso la rilevanza delle comparazioni intersoggettive tra lavoratori al fine di determinare la retribuzione commisurata alla quantità e qualità del lavoro da loro prestato. Tra l'altro, una breve riflessione mostrerebbe che le difficoltà in cui s'incorre quando si voglia procedere ad una comparazione intersoggettiva fra lavoratori diversi non sono logicamente dissimili da quelle che s'incontrano quando si voglia procedere al confronto intertemporale delle prestazioni rese da un medesimo lavoratore - insormontabili le une, insormontabili le altre. Di questo limite si sono resi conto anche alcuni economisti neoclassici, i quali sono giunti alla conclusione (invero apparentemente sconcertante) che la norma contenuta nell'articolo 36 è priva di senso. Non sembra invece che ne siano consapevoli quanti - a cominciare da Confindustria e Cisl - richiedono una riforma della contrattazione che leghi maggiormente «il merito e il salario», come sintetizzava efficacemente il titolo di un editoriale di Pietro Ichino sul Corriere di martedì scorso. Conviene allora ribadirlo con nettezza: merito e salario non sono e non possono essere legati in alcun modo, salvo che accollando al lavoratore il rischio d'impresa, cioè riversandogli le conseguenze di scelte organizzative e gestionali alle quali egli è per definizione estraneo. Non è un caso che l'articolo 36 non si limiti a dire che la retribuzione dev'essere commisurata alla quantità e qualità del lavoro prestato, ma aggiunga che dev'essere «in ogni caso sufficiente» ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia «un'esistenza libera e dignitosa»: c'è qui l'eco dell'insegnamento di Marx, secondo cui il salario non è il prezzo del "lavoro" ma della "forza-lavoro", cioè dell'astratta capacità umana di erogare energie fisiche e mentali, che diventa oggetto di scambio nel contratto di lavoro subordinato, forma giuridica tipica (sebbene ormai non unica) del lavoro salariato. Se ciò è vero, l'unico incentivo che si può riconoscere ad un lavoratore che faccia bene il proprio mestiere può essere costituito da un rapporto di lavoro che, per durata e retribuzione, quell'esistenza libera e dignitosa torni a garantire. Non serve affatto intervenire sulla contrattazione collettiva. E' senz'altro vero che la determinazione del salario a livello nazionale avviene prescindendo dai differenziali di produttività esistenti tra impresa e impresa, ma è altrettanto vero che questa uniformità della crescita del salario in tutto il sistema economico può costituire un rilevante incentivo alla diffusione del progresso tecnologico. L'uniformità della crescita del salario nel tempo genera infatti squilibri in tutti i settori produttivi in cui la crescita della produttività avviene ad un saggio diverso rispetto alla media (più esattamente, genera perdite là dove la produttività cresce in misura inferiore rispetto al saggio di incremento del salario e sopravvenienze attive in quei settori in cui la produttività cresce ad un saggio maggiore) e gli squilibri possono favorire ristrutturazioni e innovazioni, dunque accrescere la capacità competitiva del Paese. Si dovrebbe aggiungere che, quando ciò non avviene, è segno che le imprese sono riuscite a scaricare altrove le conseguenze della propria inefficienza. Ne abbiamo già scritto su queste colonne il 23 novembre scorso: durante gli anni '80 e fino alla prima metà dei '90, sono state le svalutazioni della lira a consentire alle imprese di eludere la frusta dell'innovazione (di prodotto, e non solo di processo) senza compromettere la loro capacità di competere con l'estero. Dalla seconda metà degli anni '90 in poi, con l'ingresso del nostro Paese prima nella banda ristretta e poi nella moneta unica, il giochetto però è diventato impossibile e si è ricorsi - complice la débâcle politica e culturale della sinistra - alla precarizzazione del lavoro, in modo da consentire alle imprese di recuperare sul versante del suo costo d'uso i margini di profitto erosi dalla minore competitività dei loro prodotti. Così stando le cose, accusare il contratto nazionale di essere una "gabbia" responsabile del dualismo del mercato del lavoro è fuorviante: quel dualismo è figlio del declino tecnologico, ovvero - per dirla con un aureo libretto di Luciano Gallino - della «scomparsa dell'Italia industriale». Dietro il tentativo impossibile di legare "merito e salario" si cela semplicemente la volontà di accollare ancora ai lavoratori le conseguenze della miopia strategica di un sistema di imprese gestito su base familistica e votato alla nicchia o alle rendite da monopolio. E continuare a garantire a un padronato nullafacente quanto arrogante una comoda assicurazione contro il rischio dei propri fallimenti è l'ultima delle cose di cui c'è bisogno per invertire la rotta della crisi economica e civile che stiamo vivendo. |