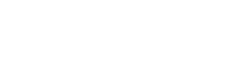19/4/2004 ore: 0:00
Disposizioni in materia di sicurezza sussidiaria
Contenuti associati
-
Considerazioni di Filcams, Fisascat e Uiltucs in merito al testo unificato in Commissione Affari Costituzionali della Camera riguardante “disposizioni in materia di sicurezza sussidiaria”
Roma 13 aprile 2004
Il movimento sindacale da anni ha posto come esigenza prioritaria del settore della Vigilanza Privata, la definizione di un quadro giuridico e normativo riformato in sintonia con l’evoluzione strutturale verificatasi, in particolare, nell’ultimo decennio.
Non possiamo quindi che salutare positivamente l’avvio di una discussione nelle sedi istituzionali preposte, che si pone l’obiettivo di realizzare una riforma compiuta del settore della vigilanza privata.
Come sempre avviene quando si parla di proposte legislative, che produrranno un impatto molto incisivo sul futuro delle imprese e degli operatori, è buona cosa partire da un’approfondita analisi del merito.
L’attuale assetto legislativo, sancito dal testo unico di P.S., è superato dall’evoluzione del tempo ed è convinzione unanime che necessiti una sostanziale modifica più aderente alle funzioni della Vigilanza Privata nella società post-industriale, tale da assecondare lo sviluppo e l’ammodernamento in un’epoca di profonde e veloci mutazioni tecnologiche particolarmente attive nel campo dei sistemi di sicurezza.
Analisi e riflessioni già a suo tempo sottoposte all’attenzione delle Istituzioni preposte e con le quali si sono tenuti incontri per confronti di merito, senza mai pervenire ad iniziative concrete per la soluzione degli annosi problemi che riguardano il settore della Vigilanza Privata, propongono l’esigenza di un intervento di riordino legislativo che si fa più forte a causa delle mutate condizioni di mercato e del progressivo venir meno di un’etica commerciale e di leale concorrenza fra le imprese, provocata da un atteggiamento della committenza pubblica e privata volto unicamente al contenimento dei costi a scapito della qualità del servizio reso.
Contestualmente l’evoluzione della tipologia stessa del servizio di sicurezza, vigilanza e custodia che si sta manifestando ed affermando in modo assolutamente spontaneistico, senza vincoli e regole, genera tensioni interne che sconvolgono il normale e naturale equilibrio strutturale sancito dalle vigenti norme che regolano il settore.
L’obiettivo prioritario quindi è quello di dare certezze ad un mercato attraverso norme che stabiliscano ruoli e competenze sia per quanto riguarda le imprese che per gli operatori.
Ruolo del settore – Natura del servizio
Operando in un settore come quello della sicurezza, la natura del servizio riveste un’evidente delicatezza.
Un presupposto che va riconfermato e riportato correttamente all’interno della natura dei servizi chiamati a svolgere, risiede nell’esclusiva funzione di prevenzione di furti e rapine e/o custodia del patrimonio privato, mobiliare e immobiliare dei cittadini, aziende o enti; occorre in ogni caso tener conto delle evoluzioni strutturali in corso nel settore con particolare riguardo alle attività di trasporto valori con tutte le azioni e le operazioni ad esse connesse, ivi compresa la contazione, le attività di tele allarme, la vigilanza satellitare, la consegna dei medicinali e domicilio, i parcheggi pubblici e privati, ecc.
Gli Istituti di Vigilanza pertanto sono da considerarsi aziende private a tutti gli effetti giuridici e non possono e non debbono attribuirsi compiti che sono propri delle forze di Pubblica Sicurezza dello Stato, così come sancito dalla Carta Costituzionale.
Di conseguenza il ruolo del settore non può che distinguersi all’interno di una logica privatistica che superi le ambiguità e gli equivoci del passato circa il posizionamento del settore della Vigilanza Privata in una sfera di attività “paramilitare”.
In questo senso riteniamo opportuno che nella riforma sia ben circoscritto questo ambito di attività, e la natura privatistica delle funzioni delegate alla Vigilanza Privata.
Per questo s’individuano alcune contraddizioni nel testo in discussione in commissione della Camera nel quale (dall’articolo 1° dove si stabilisce l’ambito di attività), restano ampi margini di ambiguità e di discrezionalità.
Per questo riteniamo opportuno che in maniera esplicita sia stabilito che le attività di sicurezza delegate al settore non devono in alcun modo comportare l’esercizio di potestà pubbliche o limitazioni delle libertà personali, così come i servizi di sicurezza e vigilanza non possono comportare l’uso di armi o di coercizione fisica, se non limitatamente alla tutela del bene mobile o immobile che si è chiamati a preservare,ed alla legittima difesa.
In nessun caso ad imprese di natura privatistica possono essere delegati compiti di ordine pubblico.
In sostanza deve rimanere esclusiva la competenza della Vigilanza Privata nel campo della prevenzione del reato contro il patrimonio, e solo eccezionalmente, in situazioni ben specificate, nella sua repressione.
Per questo è contraddittoria la previsione di agevolazioni finanziarie e fiscali “agli istituti che assolvano a funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza”.
La natura giuridica della Guardia Particolare Giurata
In questo contesto si valuta positivamente la definizione della GPG come Incaricato di Pubblico Servizio, così come l’attribuzione di alcune prerogative che sono finalmente riconosciute a questi operatori, come ad esempio la possibilità di stilare verbali che fanno fede sino a prova contraria, e la chiarezza fatta in campo di arresti in flagranza di reato.
Troppo vago invece è ancora il quadro relativo al rapporto con gli organi di Pubblica Sicurezza e Polizia Giudiziaria.
Troppo generica e senza limiti appare la dizione “sono tenute a aderire a tutte le richieste ad esse rivolte dagli ufficiali di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria.”
La riconferma della natura privatistica delle attività degli Istituti di Vigilanza, non può certamente far venire meno l’esigenza di un coordinamento della loro attività da parte dello Stato, attraverso gli organi a ciò preposti –Prefetture e Questure-, finalizzato ad assicurare livelli congrui di sicurezza per i cittadini.
Ma anche qui il limite deve essere sempre quello fissato dalla prevenzione del delitto che si è tenuti a tutelare, escludendo altre eventuali attività.
Come detto è evidente che nella flagranza di reato la Guardia Particolare Giurata deve operare in ausilio con le forze dell’ordine, e quindi in questo frangente assumerà temporaneamente la qualifica di pubblico ufficiale. Non è al contrario condivisibile una generale estensione delle attività pubblicistiche alla Vigilanza privata, assegnando in via continuativa il ruolo di pubblico ufficiale alla GPG.
Si valuta invece positivamente l’inserimento nella riforma, e il suo ordinamento dentro il contesto della Vigilanza Privata, della Vigilanza non armata, cosa accrescerà le garanzie al settore.
Diritti e relazioni sindacali
Vi sono elementi in questo capitolo che richiedono a nostro avviso alcune correzioni.
Non condividiamo la riconferma della potestà sanzionatoria al Questore su materie che sono di esclusiva competenza negoziale e quindi stabilite dalle parti sociali. L’intervento del questore appare legittimo solo nel caso vengano meno i requisiti che hanno consentito il rilascio del decreto, e non per infrazioni che sono di natura contrattuale.
Inoltre a più riprese nel testo s’introduce il concetto “della buona condotta” per il conseguimento della qualifica di GPG.
Fermo restando la precondizioni di non aver precedenti penali, questo ulteriore indebito controllo della vita privata e di limitazione della liberta dell’operatore è per le OOSS un requisito da eliminare.
Così come è incomprensibile il motivo per cui gli elenchi del personale debbano essere inviati alla Questura: l’elenco della GPG è già di possesso di tutti gli organi competenti, qual è la ratio di ciò?
Formazione e titolo di studio
Estremamente corretta è l’elevazione alla scuola media superiore come prerequisito per accedere all’iscrizione al registro professionale.
Manca completamente qualsiasi riferimento alla fase transitoria, vale a dire come dare al personale attualmente in servizio, sprovvisto del titolo di studio richiesto, la possibilità di iscrizione in deroga, prevedendo ad esempio forme di formazione sostitutiva a carico delle aziende.
Troppo vago è ancora il quadro in relazione ai percorsi formativi e nulla è detto su quelli della formazione permanente del personale.
Nulla è esplicitato sulla consistenza di questi percorsi, tra l’altro individuando il Ministero come unico soggetto con potere decisionale, escludendo aprioristicamente le parti sociali dalla potestà di definizione dei programmi.
Si evidenzia inoltre la contrarietà di queste OOSS su due questioni:
-la possibilità che a gestire i corsi possano essere delegate le aziende,
-che la partecipazione ai corsi di formazione possa essere posta a carico dei partecipanti
Registro professionale
L’istituzione di un elenco professione al quale obbligatoriamente le aziende debbano ricorrere, è una richiesta che come OOSS abbiamo avanzato da tempo.
Crediamo però che l’attuale impostazione data dal testo della riforma vada in alcuni punti meglio specificato.
Innanzi tutto va definito come si tutelano i livelli occupazionali, evitando di tramutare questo registro in un’area di parcheggio per la disoccupazione di lunga durata.
Appare poi contrastante l’istituzione del registro nazionale, ambito che noi riteniamo corretto, con la creazione di un ulteriore, non ben identificato, “albo provinciale” previsto all’art 12 e ripreso all’art.14. Questo secondo livello appare fuorviante, e rischia di inficiare il ruolo primario del registro nazionale, e pertanto se ne richiede la soppressione.
Anche la definizione del registro nazionale ha alcuni elementi che fanno pensare ad un vero proprio albo professionale, che non è nelle intenzioni del sindacato istituire. L’obiettivo deve essere una regolamentazione ed una registrazione che garantisca il possesso dei requisiti, non una burocratizzazione, con venature un po’ corporative.
Inoltre appare non condivisibile la limitazione temporale dell’iscrizione al registro, che non deve essere ancora legata alla permanenza in servizio. Nel testo si riconferma la prassi odierna della perdita della qualifica al momento del licenziamento (nel testo dopo trenta giorni).
A nostro avviso se è corretta la previsione della sospensione del decreto e del porto d’armi dal momento in cui non si è operativi, appare ingiustamente penalizzante la perdita della qualifica.
Se deve essere prevista una decadenza occorrerà stabilire una temporalità molto ampia (ad esempio due anni) che consenta agli operatori di rientrare nel mercato del lavoro (anche attraverso riqualificazione), e nel frattempo prevedere l’obbligo per le aziende di attingere prioritariamente da questo personale in caso di assunzione del personale.
Autorizzazioni e controllo delle imprese.
Il nuovo sviluppo del mercato in questo settore impone, come detto, una maggior attenzione alle capacità tecniche ed operative delle aziende che svolgono questo delicato servizio.
Bene quindi fa la bozza di riforma ad introdurre tra i criteri all’art. 2 un prerequisito tecnico indispensabile al rilascio della licenza.
Tale concetto, ripreso più ampliamente in un articolo successivo, rimane nel testo molto nel vago, senza chiarire né cosa significhi né chi ne definisce i requisiti, delegando addirittura ad un’autocertificazione la definizione di tale caratteristiche tecniche.
Al fine di contrastare ciò che già ampiamente avviene sul territorio nazionale, dove molto spesso le aziende disattendono le minime norme già oggi vigenti, senza che le autorità competenti intervengano, si ritiene che il Ministero stesso debba con proprio atto definire le caratteristiche e i requisiti ai quali l’aziende debbano scrupolosamente attenersi a secondo dei servizi da effettuare.
Tariffa di legalità
Data l’importanza che sempre più rivestirà questo strumento, ci preme sottolineare come, pur condividendo l’impostazione di una definizione nazionale della tariffa, occorrerà trovare un correttivo che tenga in considerazione gli elementi aggiuntivi che scaturiranno dalla contrattazione decentrata, livello esplicitamente previsto dal CCNL. Si ritiene opportuno altresì definire i riferimenti tariffari per le gare di appalto a livello nazionale.
Commissione Consultiva Centrale
L’istituzione di questa commissione che tende a coinvolgere la parti sociali è certamente un elemento innovativo. La sua composizione invece andrebbe più attentamente analizzata, eliminando una certa ridondanza di presenza burocratica, così com’è incomprensibile che alcune figure dirigenziali, cooptate dal registro professionale, siano inserite d’ufficio, introducendo un criterio corporativo della rappresentanza.
Se deve essere una Commissione espressione dei soggetti operanti nel settore dovrà essere tenuta in debita considerazione la presenza delle parti sociali maggiormente rappresentative.
In tale filosofia pensiamo che analoga commissione consultiva dovrà essere istituita a livello provinciale, sotto la direzione della Prefettura, per dare la propria valutazione sulle problematiche inerenti alle evoluzioni strutturali del mercato della Vigilanza e attività connesse e/o collaterali allo stesso, fornendo alle Istituzioni preposte indicazioni di merito e possibili orientamenti per la risoluzione delle eventuali contraddizioni riscontrate, e siano da supporto per la valutazione di merito nell’analisi delle opportunità di rilascio di nuove licenze.